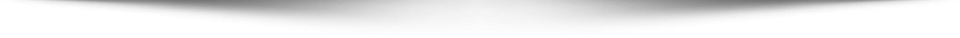L’aeroporto nell’antico Cannamellito.
Pur non appartenendo oggi al territorio di Vittoria, non c’è dubbio che il nuovo aeroporto civile di Comiso è anche “cosa nostra” e non solo per la vicinanza, ma perché l’area in cui oggi sorge la struttura fino al 1937 appartenne formalmente a Vittoria e solo per motivi politici fu tolta al nostro Comune, grazie all’azione dell’archeologo Biagio Pace, allora deputato ed uno dei maggiori esponenti del Fascismo ragusano. In concomitanza infatti con la scelta strategica del governo Mussolini di creare un aeroporto al Cannamellito sin dal 1927, il Comune di Comiso lo stesso anno chiese di staccare dal territorio di Vittoria proprio le contrade Cannamellito e Serra Calcara per ettari 649 ed aggregarle a Comiso. Non se ne fece nulla, mentre le pratiche per la costruzione del nuovo aeroporto militare andarono avanti fino all’inizio dei lavori, nel luglio 1935 e furono portati avanti come se la zona appartenesse a Comiso1, espropriando 146 ettari di terreni alle famiglie Jacono e Ferreri di Comiso, Jacono Rizza, Benso ed altre di Vittoria. Poi con legge 10 giugno 1937, per intervento dell’on. Biagio Pace, i 620 ettari delle contrade Cannamellito e Serra Calcara passarono da Vittoria a Comiso (con un indennizzo per Vittoria di ettari 1040 su Biscari…). La contrada era prima nota con il nome di Bosco Rotondo. Di essa abbiamo notizia sin dal 1409, quando si individuarono i confini della foresta di Camarina o Boscopiano nel Quinterno dei feudi di Bernardo Cabrera (Monello), conte di Modica (cfr. Monello, L’eredità camarinese e l’invenzione del “reaedificetur Camarina”. La zona era coperta da boschi (da cui il nome), verosimilmente di querce da sughero (come per Boscopiano) ma fu coinvolta nel grande processo di frammentazione del feudo modicano iniziato nel 1550, quando 6 partite di terra furono assegnate a Bosco Ritondo (Sipione). Al momento della fondazione di Vittoria, i primi del Seicento, la zona era seminata ad orzo2 e sulle terre la Contea nel 1714 e nel 1748 pagava censi al Monastero di Santa Lucia di Siracusa3.
La nuova denominazione da Bosco Rotondo a Cannamellito è dovuta all’esperimento di coltivazione di canna da zucchero e produzione di zucchero fatto su iniziativa della contessa Luisa de Sandoval, moglie del viceré Giovanni Alfonso Enriquez Cabrera (1596-1647), figlio di Vittoria Colonna, fondatrice di Vittoria. Impiantato nel corso del 1641, il Cannamellito cominciò a produrre l’anno successivo e fu solennemente inaugurato nell’ottobre 1643, in occasione della venuta dei conti a Vittoria (dove alloggiarono nel castello per una notte). Per finanziare la assai costosa iniziativa (fu anche costruito un grande trappeto da zucchero), Vittoria contribuì con i terraggi pagati sulle terre dagli enfiteuti, il ricavato della gabella della macina dei due mulini, le entrate della Scaletta e quelle della vendita della giurgiulena, della tumminia (grano tenero) e delle ghiande prodotte a Bosco Rotondo4. L’investimento in un biennio (più di 3.000 onze) si dimostrò poco redditizio sia l’alto costo della manodopera sia per il clima dell’area, assai lontano da quello tropicale necessario alla produzione ottimale (del resto il Seicento fu un secolo di grandi freddi). Pertanto, già agli inizi del 1645, l’impianto fu smantellato e alla terra rimase il nome di Cannamellito (per notizie complete vedi box)
|
Box: L’industria dello zucchero a Vittoria (1641-1645) La vicenda dell’industria dello zucchero a Vittoria, pur durata pochissimo, è esemplare ed interessante e caratterizza sin dall’inizio il nostro territorio come vocato a colture specializzate: vino, zucchero, pomodoro, fiori. Servendomi degli studi reperibili ecco quanto sono riuscito a ricostruire: In genere il raccolto si faceva a dicembre, ma probabilmente per il primo anno, la raccolta avvenne più tardi, se è vero che il prodotto fu portato da circa 150 muli e da decine di bordonari al trappeto del duca di Terranova ad Avola, con una notevolissima spesa, con salari giornalieri che andavano da tarì 2.10 a 4.10. Nel trappeto di Avola poi bisognò pagare oltre 70 operai per numerose giornate di lavoro, con salari che andavano da 10 grana a tarì 2.6. b) seconda fase: gestione di Pietro Puy. La costruzione del trappeto. I costi per portare la cannamele ad Avola dovettero però sembrare assai pesanti, per la qual cosa si pensò di costruire un trappeto sul posto. La cosa coincise con il passaggio dell’amministrazione a Pietro Puy (22 febbraio 1643), un funzionario spagnolo all’epoca a Vittoria, dove ricoprì anche la carica di secreto. La superficie del cannamellito fu portata a 6 salme e furono ingaggiati 6 calabresi a tarì tre al giorno per fare le saie dentro e fuori l’arbitrio (cioè la superficie del cannamellito) e poi per pulire la vecchia saia che portava l’acqua da Cifali alla piantagione. 18 chiantaturi di ferro furono acquistati per piantare i talli. La piantime (fatta venire da Avola, con 55 muli) fu messa a dimora da una squadra di 36 avolesi, guidati da un cialauru6, tale Antonio Mantua. Zappatura, concimazione, irrigazione furono tutte operazione svoltesi da marzo a maggio e poi la sola irrigazione fino a tutto settembre. Ma già dai primi di aprile 1643 si era individuato il sito del trappeto. Per sceglierlo erano stati incaricati due mastri di Ragusa, con una cerimonia solenne alla presenza del barone Bernardo Valseca, mastro razionale del Patrimonio e del governatore don Francisco Echelbez, entrambi venuti in lettiga da Vittoria. I due amministratori erano accompagnati dai servi e da uno schiavo (di Echelbez) e furono preceduti dal suono di un trombettiere montato su una mula. I mastri Silvestro Dierna, Francesco e Filippo di Marco, tutti di Ragusa, ebbero l’appalto per la costruzione del trappeto (e due di loro furono quelli che scelsero il sito). L’estensione della costruzione, è dimostrata sia dalla gran quantità di legname portato in parte da Cifali e in parte da Mazzarrone, dove fu lavorato sul posto da Vincenzo Mavila di Vittoria, sia dall’enorme quantità di tegole occorse per i tetti (ben 32.000), costruite a Vittoria da mastro Guglielmo di Modica, ciaramiraru e mattunaru. I forni (in numero di 7) per cuocere le forme di terracotta contenenti la melassa, furono realizzati con mattoni (27.000, di cui 2.000 servirono per il pavimento dell’ambiente). Li costruì mastro Giovanni Gaudioso, fatto venire apposta da Palermo. Mastro Geronimo di Naro di Vittoria costruì i coperchi (129 per i conzi dei torchi del trappeto, impiegando in totale 225 rotoli di ferro (cioè 180 kg). 4 grandi mezze botti vecchie furono usate per impastare la creta per la costruzione dei forni. Altre attrezzature in ferro furono fornite da mastro Bernardino Milazzo. Le caldaie furono fatte venire da Palermo, via mare, a Pozzallo. Il trasporto fu organizzato da Giuseppe Pullarella di Modica, a mezzo di lettighe. Le caldaie in tutto erano otto: tre grandi (pesavano in tutto cantara 6 e rotoli 24, cioè circa 500 kg), 4 mezzane ed 1 piccola (pesanti in tutto cantara 9 e rotoli 6, pari a kg. 768). Dal costo elevato (3 onze) del fondo della maidda in cui veniva versata la melassa, si deduce la sua grandezza: era lunga infatti palmi 15 (cioè m. 3,75) e larga palmi 5 (m. 1,25), costruita da mastro Francesco Licitra, in noce. Purtroppo abbiamo poche indicazioni per la parte che riguarda le macine. Sappiamo però che le mole furono fatte venire da Palermo via mare fino a Pozzallo e da lì trasportate a Scoglitti su due barche, con un compenso di onze 4 ai due patron Giuseppe Montalto e Domenico Messina. Tre mastri di Avola lavorarono 5 giorni per sbarcare le mole. Fu costruito un “ponte” per scenderle dalle barche e poi trasportarle fino al Cannamellito. Organizzò tutta l’operazione mastro Carmelo Oddo di Avola, che infine le calò nel trappeto (ebbe in tutto onze 5.1). Sotto la direzione di mastro Giovanni Gaudioso fu realizzata la gorga e la saja per la ruota che doveva far muovere le mole dei torchi (che sappiamo essere più di uno): per questo lavoro furono ingaggiati i soliti calabresi, esperti anche nella ripulitura della saja dopo la macina. Il lavoro della saia fu prezzato dal capomastro vittoriese Francesco Adamo (tutti i lavori vengono stimati da terzi). Il tetto ed i due fusi (uno delle mole ed uno del torchio) furono realizzati con legname di Mazzarrone (dove andò a lavorare mastro Vincenzo Mavila con il figlio Antonino) e da mastro Luca (di cui non viene detto il cognome). Ogni fuso era alto palmi 30 (cioè metri 7,50) e per portare fuori dal fiume di Roccazzo (il Mazzarronello) l’albero da cui fu ricavato quello del torchio ci vollero 4 persone. Per stringere il conzo furono costruite sei stanghe (se il funzionamento era come quello del conzo dei palmenti, esse venivano inserite dentro il fuso in apposite cavità e girando attorno all’asse le mole si alzavano mediante una gigantesca vite). Numerosi tronchi di àlbano furono utilizzati per costruire le travi del tetto. Furono costruite in tutto 20 viti di legno (ma purtroppo ne ignoriamo la funzione e la posizione nei torchi). Dai tronchi di albano provenienti dal Passo di Cammarana furono realizzate altre travi per il tetto dell’edificio (lavorati dai mastri Stefano di Marco, Giovanni Bucchieri, Vincenzo e Francesco di Franco). Il trappeto fu visitato a fine ottobre, durante il suo soggiorno a Vittoria da Giovanni Alfonso, allora viceré, nel corso della visita alla sua Contea. La venuta del viceré, accompagnato dalla moglie, da una figlia, dal figlio primogenito Giovanni Gaspare e dalla nuora, fu salutata dallo sparo di 60 maschi, ad opera di mastro Melchiorre Giunta. La prima cotta fu fatta il 17 novembre 1643, alla presenza di don Francisco Bolle (procuratore del Conte), festeggiata dallo sparo di 100 maschi (ad opera di mastro Innocenzo Giarratana). Occorse una gran quantità di legname per la prima cotta, costata ben 80 onze e trasportata al trappeto da 69 bestie e 22 bordonari (pagati ad un tarì al giorno). Organizzatore di tutta la complessa opera di raccolta e cottura delle canne fu mastro Giuseppe Pensabene (che arruolò tutti gli operai, in gran parte di Petralia), mentre responsabile della produzione dello zucchero, cioè mastro degli zuccari, fu mastro Antonio la Scola. Oltre la prima cotta, ne sono documentate altre 15 (dall’11 gennaio 1644 al 18 febbraio), con un ritmo che è da immaginare infernale… Il gran numero di qualifiche (una trentina), ciascuna per un compito specifico e limitato, ci fa pensare ad una complessa macchina organizzativa, a segmenti di una vera e propria catena di montaggio che dalle canne del campo portava al prodotto finito: i panetti di zucchero. Dopo aver lavorato a compenso nella costruzione del trappeto e dei forni, ritroviamo anche mastro Filippo di Marco, salariato giornaliero come mastro di macina; ed anche mastro Giovanni Gaudioso, come mastro di fabbrica e cunzaturi di furna. A giornata risulta pagato anche un acqualoro di gorga (di Vizzini), garante del regolare flusso dell’acqua nella ruota per la macina.
Altro fatto importantissimo è che, mentre il periodo richiesto dalla canna per maturare è di circa 12 mesi nelle zone tropicali e sub-tropicali, e ne sono sufficienti 9 in quelle equatoriali, in Sicilia, secondo le indagini effettuate in proposito dal Bianca, la raccolta si era sempre praticata intorno al 10° mese di vegetazione «onde evitare che il sopraggiungere dei rigori invernali compromettesse la vita dei futuri germogli». Inoltre, occorrevano anche enormi quantità d’acqua e di legna per la raffinazione. L’attività del Cannamellito cessò dunque ai primi del 1645. Il 22 febbraio fu redatto l’inventario dei beni e di zucchero non si parlò più. Ma rimase il nome alla contrada… *** Del feudo si parla nel rivelo del Conte del 1811-16, diviso tra la Contea ed il Monastero di Santa Lucia di Siracusa. In parte l’ex feudo risulta concesso in enfiteusi al barone don Bartolomeo Ferreri di Comiso, con un censo al Conte di Modica pari ad onze 200. Ad inizio degli anni ’50 dell’Ottocento, Bosco Rotondo -come ci dice Orazio Busacca- risulta in «proprietà del Signor don Antonio Iacono fu Giacchino» e Cannamellito (salme 38) in mano a don Ferdinando Jacono (1804-1863). Don Ferdinando Jacono ne piantò 24 salme a vigne poi nel 1859, convintosi di non potercela fare a coltivarle, per l’alto costo della manodopera e non volendo utilizzare la nuova invenzione del cosiddetto aratro a scocca fatta da Orazio Busacca8, le divise in 24 lotti e li vendette ad altrettanti coltivatori, fra cui lo stesso Busacca. Per sé trattenne però una parte delle vigne, che fece coltivare con la zappa, nel modo tradizionale. Ma appena si accorse che le vigne concesse, coltivate con l’aratro a scocca avevano una migliore vegetazione, pentitosi, fece di tutto per rientrare in possesso delle vigne, avendo buon gioco a recuperarle in quanto la vendita era stata rateale ed era stata pagata solo la prima rata. Per questo i suoi eredi, sia Jacono di Comiso che Jacono-Rizza di Vittoria (questi ultimi avevano costruito sul posto una villa, chiamata appunto Villa Jacono) risultarono proprietari dei terreni espropriati per la costruzione del nuovo aeroporto, intitolato al gen. Vincenzo Magliocco, ucciso in un agguato in Abissinia nel novembre 1936. Inaugurato da Mussolini il 14 agosto 1937, dopo l’entrata in guerra dell’Italia fu usato dall’aviazione italiana e tedesca per bombardare Malta. Più volte colpito dagli Inglesi tra il 1941 ed il 1942, fu completamente distrutto tra il maggio ed il luglio 1943. Riutilizzato come aeroporto civile negli anni ’60, fu chiuso definitivamente nel 1973. |
NOTE
1] Sulla vicenda cfr. Giancarlo Francione, Aquile sugli Iblei. Storia dell’aeroporto di Comiso dalle origini al 10 luglio 1943, 2008
2] Uno dei coloni insediato a Bosco Rotondo era Benedetto Spataro, cognato di Paolo Custureri, primo secreto di Vittoria.
3] L’ex feudo di Bosco Rotondo, esteso salme 797 (cioè 1404 ettari) confina con le contrade Micciché, Fontana Volpe, Corallo e Niscima.
4] Per un totale di 200 onze su oltre 2000.
5] G. Bianca, Monografia agraria del territorio di Avola
6] Una sorta di stregone e indovino, capace di comandare alle bestie…
7] Rosario Termotto, Contratti di lavoro e migrazioni stagionali nell’industria zuccheriera siciliana, Mediterranea 2012 (on line)
8] L’aratro a scocca consisteva in un aratro di ferro tirato da un solo animale, adatto pertanto alla vigna
.